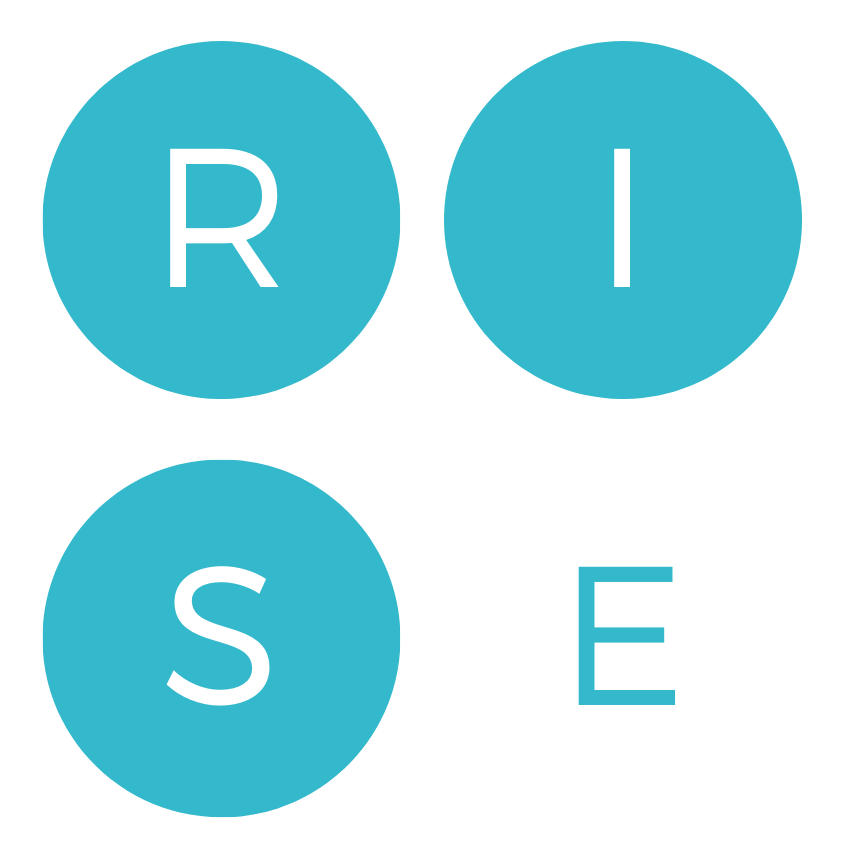Stiamo scivolando lentamente verso un baratro che non riusciamo a percepire, come sonnambuli incapaci di svegliarsi prima di un precipizio ormai troppo vicino, prima di una caduta da cui non ci sveglieremo di soprassalto ma che ci sbatterà in faccia una realtà ineluttabile: il collasso dell’ecosistema planetario su cui per millenni le nostre civiltà si sono sviluppate e hanno prosperato. L’unica certezza è che nel prossimo futuro tutto cambierà e la natura di questo cambiamento dipende dalle azioni che la nostra specie compirà nei prossimi anni. La scelta da affrontare si riduce a un semplice bivio: la via della transizione economica, sociale e culturale che ci allontana dal precipizio o la strada, sempre più scoscesa, che ci porta dritti ad esso.
Non vi è minaccia tanto impellente quanto trascurata come quella che va sotto il nome di cambiamento climatico. È al tempo stesso la più grande sfida collettiva mai affrontata, il più stravolgente fallimento di mercato e il più diffuso caso di procrastinazione di massa che si sia mai verificato, in un contesto in cui le nazioni e i cittadini dell’intero pianeta sembrano come intrappolati in un profondo stato di inerzia. Stiamo vivendo quello che alcuni economisti chiamerebbero un fenomeno universale di free riding e moral hazard in cui la gran parte dei governi, imprese e cittadini è nella pratica poco incline a sobbarcarsi i costi ed intraprendere la via di un deciso cambio di rotta a beneficio dell’ecosistema e del nostro sistema economico-sociale mentre, a causa di incertezze ed egoismi individuali, si va incontro ad un malessere comune così grande che ogni inazione risulta inaccettabile.
Per cambiamento climatico si intende una variazione delle dinamiche e fenomeni climatici di lungo periodo causati dall’incremento della temperatura media planetaria. Il processo di riscaldamento globale è dovuto a sua volta alle emissioni di gas serra nell’atmosfera come conseguenza delle attività economiche umane. Tale fenomeno è iniziato a seguito della rivoluzione industriale ed è lentamente cresciuto per esplodere esponenzialmente nell’ultimo mezzo secolo, con un tasso di incremento delle emissioni che fino ad adesso, a livello globale, non mostra alcuna diminuzione sostanziale. Nell’era precedente la rivoluzione industriale il livello di gas serra presenti nell’atmosfera si aggirava intorno alle 270 parti per milione (ppm) di CO2 mentre, secondo le stime più accreditate, la soglia che non dovrebbe essere superata per scongiurare irreversibili e disastrosi effetti sugli ecosistemi si assesterebbe fra le 450 e le 550 ppm; sono in molti a sostenere che il superamento di tale limite innescherebbe fenomeni di aumento esponenziale del processo di riscaldamento che renderebbero il fenomeno ormai totalmente fuori controllo. Il mese di settembre 2016 è una data storica: per la prima volta si è raggiunta la soglia permanente delle 400 ppm, una concentrazione del 48% più elevata dei livelli del 1750. Solamente nel 2014 sono stati riversati nell’atmosfera più di 35,7 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente. Il termine “equivalente” indica che oltre alla CO2, anidride carbonica o biossido di carbonio, vi sono altri gas serra quali metano, ossido nitroso e gas fluorati con un potere “serra” molto più profondo e duraturo rispetto alla comune CO2.
Rintracciare con esattezza e univocità quali siano le attività economiche più impattanti e il loro peso relativo risulta molto complesso ma, al fine di comporre un quadro generale, è possibile elencare a grandi linee i vari settori che contribuiscono all’emissione dei gas serra e il loro contributo alla progressiva destabilizzazione dell’ecosistema planetario. Come è facile aspettarsi, il primato spetta all’insieme di attività finalizzate alla produzione elettrica e di calore che, largamente alimentate da carbone e gas, generano circa il 25% delle emissioni totali (in questa cifra rientrano unicamente i consumi di elettricità e riscaldamento finali, ovvero non utilizzati come fattori di produzione industriale). La seconda causa in termini assoluti di emissioni è molto meno presente nell’immaginario comune: agricoltura e deforestazione. Questo comparto è responsabile del 24% delle emissioni di CO2e con la produzione di carne come vettore principale: secondo i dati forniti dalla FAO, il 14.5% delle emissioni totali di gas serra è causato dagli allevamenti e quindi dalla produzione di carne e prodotti caseari. All’interno di questo dato spicca con un determinante 65% l’allevamento di bovini da carne e da latte, rendendo quindi il consumo di carne bovina fortemente insostenibile. La terza fonte di emissioni è rappresentata invece alla produzione industriale (con l’esclusione del settore delle costruzioni che da solo genera il 6% di gas serra). Il comparto industriale genera un buon 21% complessivo di emissioni, dovute principalmente alla combustione di fossili a fini energetici e al settore metallurgico ed estrattivo. Infine, il settore trasporti è responsabile del 14% di CO2e, seguito da un restante 10% derivante da attività comunque collegate al settore energetico ed industriale.
Da un punto di vista geografico e politico, ad oggi, non esiste un attore più grande e determinante della rombante Cina. Dal paese del dragone si sollevano ogni anno miliardi di tonnellate di gas serra: in termini relativi, si stima che la Cina da sola sia responsabile del 27.4% delle tonnellate di CO2e emesse, seguita dagli USA (15.7%) ed UE-28 (10.8%). Con un semplice calcolo risulta chiaro che questi 3 attori contribuiscano oggi a più della metà del fenomeno di riscaldamento globale. Al fine di determinare chi debba farsi maggiormente carico della “responsabilità climatica” bisogna però considerare il tasso di emissioni su un arco storico ampio. Considerando le quantità di gas serra emesse dal 1850 al 2011, il podio della responsabilità assume proporzioni differenti: esso vede la Cina al gradino più basso (11%), il blocco europeo al secondo (25%) e la medaglia di carbonio saldamente al collo degli USA, con uno stupefacente 27%. Questo spiega alcune delle fratture evidenti nelle negoziazioni internazionali in tema climatico che si sono succedute negli ultimi decenni, con i paesi in via di sviluppo quali Cina, India e Brasile risoluti nel rivendicare il diritto di intraprendere un rapido e profondo sviluppo industriale supportato dell’impiego su larga scala delle energie fossili.
Sebbene le responsabilità storiche siano più che evidenti, assistiamo a un triste paradosso riguardante gli effetti, già attuali e ancor più futuri, del processo di cambiamento climatico. Coloro che subiranno maggiormente i sintomi della febbre planetaria sono e saranno quei paesi e società che meno di tutti hanno contribuito al fenomeno e che hanno quindi usufruito meno o nulla dello sviluppo industriale su base fossile degli ultimi secoli. I paesi poveri e in via di sviluppo saranno quelli maggiormente colpiti dagli effetti del surriscaldamento globale, sia per il grado di minore resilienza e maggiore esposizione dei loro ecosistemi al fenomeno, sia per la loro incapacità nell’affrontare e mitigarne i suoi effetti, dovuta alla condizione di arretratezza economica, tecnologica e di governance.
Fiumi d’inchiostro sono stati già riversati per descrivere gli effetti dello stravolgimento ambientale e le sue ricadute in termini economici e sociali, ma ancora oggi, questo torrente di avvertimenti sembra non aver sortito l’effetto desiderato. Fra le conseguenze ambientali si annoverano siccità, processi di desertificazione e degradazione del suolo, scioglimento dei ghiacciai e della calotta polare, acidificazione ed innalzamento dei livelli degli oceani come anche l’aumento in frequenza ed intensità di calamità naturali quali cicloni e inondazioni, fino al collasso di interi habitat ed ecosistemi. Il tasso di biodiversità, ovvero il patrimonio naturale e genetico di cui disponiamo e da cui dipendiamo, subirà, e sta subendo, crolli epocali. A ben vedere, stiamo ufficialmente già sperimentando la sesta ondata di estinzione di massa, la prima causata dall’uomo, con un tasso di estinzione delle specie esistenti fra le 1000 e 10.000 volte più rapido di quello naturale.
Le attività economiche umane saranno ampliamente influenzate. Elementi basilari quali produzione alimentare, resa agricola e approvvigionamento idrico saranno messi a serio repentaglio in molte zone del pianeta. A titolo di esempio, nei prossimi due decenni ci si aspetta un crollo del 50% della produzione agricola nell’area sub-sahariana, del 30% nell’asia meridionale entro il 2050. A causa dell’acidificazione degli oceani (diretta conseguenza del maggiore assorbimento di anidride carbonica) e del loro riscaldamento, si assisterà a una notevole diminuzione della quantità di pesce disponibile. Quasi un sesto della popolazione mondiale vedrà le proprie riserve idriche radicalmente diminuirsi o esaurirsi. Questo fenomeno interesserà specialmente il sub-continente indiano, parti della Cina e le zone andine, in cui paesi come la Bolivia, traggono la quasi totalità dell’acqua dai ghiacciai, ormai in via di scioglimento permanente. L’Europa stessa sarà interessata in modo profondo dalle dinamiche citate. Il cambiamento climatico creerà le condizioni per aumento nella diffusione di malattie tropicali e, in generale, comporterà il peggioramento delle condizioni sanitarie a livello globale. I flussi migratori, che al momento stanno destabilizzando lo scenario politico interno ed internazionale, assumeranno secondo alcune previsioni dimensioni epocali: si stima che i rifugiati o migranti ambientali (costretti a migrare a causa della perdita delle basi eco-sistemiche delle loro economie) potrebbero raggiungere la cifra di 200 milioni di persone entro il 2050. Ancora, da molti è stata evidenziata la connessione fra esaurimento delle risorse e conflitti, facendo del cambiamento climatico anche un forte catalizzatore di conflitti locali, guerre civili e internazionali.
I campanelli d’allarme che gli esperti e la comunità scientifica hanno evidenziato negli ultimi anni risultano ormai inequivocabilmente chiari. Il 2016 è stato l’anno più caldo mai registrato, più caldo del 2015 (precedente detentore del record), e ancora prima del 2014 (anch’esso, a suo tempo, rilevato come anno più caldo nella storia delle misurazioni). Il record di temperatura media planetaria è stato superato per 3 anni di fila e ci si aspetta che il 2017 non si lasci mettere in secondo piano in questa preoccupante corsa al record mondiale. L’artico, uno degli ecosistemi più fragili del pianeta, sta già invece sperimentando aumenti di temperatura che sfiorano i 20 gradi, con una temperatura media del mare artico superiore di circa 4 gradi. Tutto ciò sta accadendo molto più velocemente di quanto ci si aspettasse: il processo di scioglimento ha visto diminuire l’estensione dei ghiacci nei mari del 30% rispetto a 25 anni fa. Gli scienziati hanno sottolineato un aspetto preoccupante: all’interno del permafrost artico e sub artico vi sono intrappolate enormi quantità di metano, gas naturale 30 volte più impattante del biossido di carbonio. Lo scioglimento di questi strati causerebbe l’innesco di una vera e propria bomba ecologica dagli effetti catastrofici. Questo processo non ha ovviamente allarmato le compagnie del settore petrolifero che, anzi, hanno visto lo scioglimento artico come un’opportunità per sfruttare i grandi giacimenti di gas lì presenti. Dopo tutto si tratta dello stesso comparto industriale che da più di quaranta anni è a conoscenza della relazione fra cambiamento climatico e combustibili fossili ma, in nome del dio profitto, ha investito milioni di dollari nel finanziare campagne di negazione del fenomeno (esemplare e vergognoso il caso riguardante la ExxonMobil).
A questo punto bisogna chiedersi cosa sia stato fatto fino ad adesso per scongiurare lo scenario catastrofico che si va profilando sempre più distintamente. La lotta al cambio climatico rappresenta l’archetipo delle sfide transnazionali, l’esempio più compiuto di una questione che, avendo cause ed effetti globali, non può che essere affrontata a livello globale, attraverso la partecipazione e collaborazione di tutti gli attori della società mondiale. Da circa 25 anni sono ormai tenuti regolarmente dei vertici internazionali atti al raggiungimento di accordi comuni riguardo le azioni e gli strumenti necessari. Dopo il fallimento del famoso protocollo di Kyoto e il disastroso summit di Copenaghen del 2009, i riflettori del mondo sono stati puntati su la COP21, tenutasi a Parigi nel dicembre del 2015. Il raggiungimento di un accordo, arrivato unicamente all’ultimo minuto, è stato presentato come un successo storico: 195 nazioni si sono impegnate nel mantenere l’aumento delle temperature planetarie al di sotto dei 2 gradi, aspirando inoltre a mantenere la soglia di riscaldamento all’interno degli 1.5 gradi Celsius. Non vi è dubbio, l’accordo di Parigi rappresenta un passo storico. Ciò che è stato concordato però non è assolutamente abbastanza. Considerando lo stadio e la magnitudine del processo di cambiamento climatico, la COP21 ha partorito un accordo debole ed inadeguato, non all’altezza della gravità e della complessità della sfida.
Il testo è affetto da una forte sconnessione fra le ambizioni riportate, e quindi il mantenimento della temperatura al di sotto dei 2 gradi, e gli impegni presi a questo fine. Recentemente un report emesso dall’UNEP ha suggerito come gli impegni presi a Parigi non combacino con l’obbiettivo dichiarato e che, mantenendoli tali, si arriverebbe comunque ad aumento di 3 gradi Celsius. Dello stesso avviso è la famosa rivista Nature, la quale in uno studio sottolinea che, anche se l’accordo venisse rispettato, sperimenteremo un aumento della temperatura media globale fra i 2.6 e i 3.1 gradi entro il 2100. Non figura all’interno dello strumento adottato una precisa scadenza per il raggiungimento del picco delle emissioni, ma ci si limita ad un ambiguo ed indeterminato “as soon as possible”. Inoltre, gli impegni presi, che vanno sotto il nome di Intended Nationally Determined Contributions, non sono legalmente vincolanti e costituiscono più che altro delle promesse di buona condotta. Fra l’altro, solo una minima percentuale delle nazioni ha avanzato piani concreti su come, e con che strumenti, voglia mantenere le proprie promesse in materia climatica. Fra le critiche maggiori che si sono levate vi è anche quella di una totale assenza di un serio meccanismo di enforcement dell’accordo, manca quindi uno schema di sanzioni utili in caso di defezione come anche degli incentivi economici, quali un’appropriata Carbon Tax, atti a favorire una rapida diminuzione delle emissioni. Il proposito a lungo termine di non superare i 2 gradi di aumento (ottimisticamente 1.5) non è supportato da alcuno strumento efficace né da alcuna iniziativa o azione congiunta che possa essere attuabile nel breve periodo. Questa, nonostante gli applausi e gli entusiasmi di Parigi, è la dura realtà da affrontare. Mentre discutiamo ancora di cosa vada fatto, e chi debba sobbarcarsene i costi, il “contatore” del nostro “carbon budget”, la quantità di gas serra che possiamo ancora riversare nell’atmosfera prima di superare la soglia dei 2 gradi, sta scorrendo senza sosta. Secondo alcuni calcoli, abbiamo già superato la quantità soglia dei 1.5 gradi. Se i capi di stato temporeggiano sui tassi di riduzione delle emissioni, la comunità scientifica ci informa che forse dovremmo già essere al punto di non solo azzerare le emissioni, ma di cominciare ad immagazzinare, in qualche modo, la CO2e emessa in precedenza.
Forse, uno degli ostacoli più grandi per l’attuazione di un serio piano di salvataggio del nostro ecosistema, risiede proprio nel modo in cui percepiamo gli obbiettivi. Da sempre ci si è concentrati sulla limitazione e diminuzione delle emissioni e si è trascurato, volutamente o no, un aspetto fondamentale. Ogniqualvolta dei nuovi giacimenti fossili vengono sfruttati, allora i combustibili estratti vengono prima o dopo utilizzati, logica questa semplice e innegabile. Secondo l’Earth League, network di scienziati ed istituti di maggior esperienza ed affidabilità a livello internazionale, se si vuole contenere l’aumento di temperatura entro i famosi 2 gradi Celsius, allora è indispensabile mantenere il 75% delle riserve fossili conosciute all’interno del sottosuolo. In uno studio si stima che tale cifra corrisponderebbe a un terzo di tutte le riserve di petrolio conosciute, il 50% di quelle di gas naturale e più dell’80% di quelle di carbone. I tre quarti dei fossili a nostra disposizione sarebbero da considerarsi quindi (in termini tecnici) “stranded assets”, ovvero dei beni che non possono (o non dovrebbero) essere sfruttati da un punto di vista di sostenibilità climatica. Ovviamente, tradurre in politiche reali un tale approccio avrebbe delle ripercussioni economiche e finanziarie di enorme impatto. Risulta lampante che in un tale contesto, esplorazioni atte ad aumentare il bacino di riserve conosciute sono totalmente incongruenti con il piano di salvataggio climatico auspicato. Ad opporsi a tale approccio sono ovviamente in primis le potenti compagnie del settore petrolifero come anche i loro investitori quali banche, hedge funds e fondi di investimento e, non ultimi, i centri finanziari che vedrebbero in tale operazione una potente fonte di instabilità e crisi.
Risulta quindi di fondamentale importanza un lucido e radicale processo di riallocazione di capitali dal settore fossile, attraverso il disinvestimento, a quello delle energie rinnovabili che negli ultimi anni stanno dimostrando un dirompente sviluppo in termini di efficienza e costi. Nei successivi vertici internazionali è assolutamente necessario raggiungere un accordo vincolante su tutte le parti che non solo preveda misure mirate a rendere non estraibile la gran parte delle riserve accumulate, ma in cui si stabilisca una tassa globale sulle emissioni che ci porti nel giro di pochi anni a raggiungere il loro picco e una progressiva radicale diminuzione. Se realmente vogliamo evitare scenari ecologicamente, economicamente e socialmente catastrofici, le nostre società devono essere pronte a prendere parte a una sostanziale diminuzione dei consumi e revisione degli stili di vita e modelli socio-economici dominanti. Non si può più pensare di delegare le scelte per una crisi così impellente all’azione dei governi e degli attori economici. Il sogno di una società dei consumi insostenibili di massa è ormai finito e ha lasciato il posto ad un incubo ecologico imminente. Abbiamo il peso e l’opportunità di essere l’ultima generazione capace di fare la differenza, l’ultima generazione che potrà dimostrare lucidità e responsabilità in una civiltà sonnambula ed in pericolo.
Giulio Porrovecchio