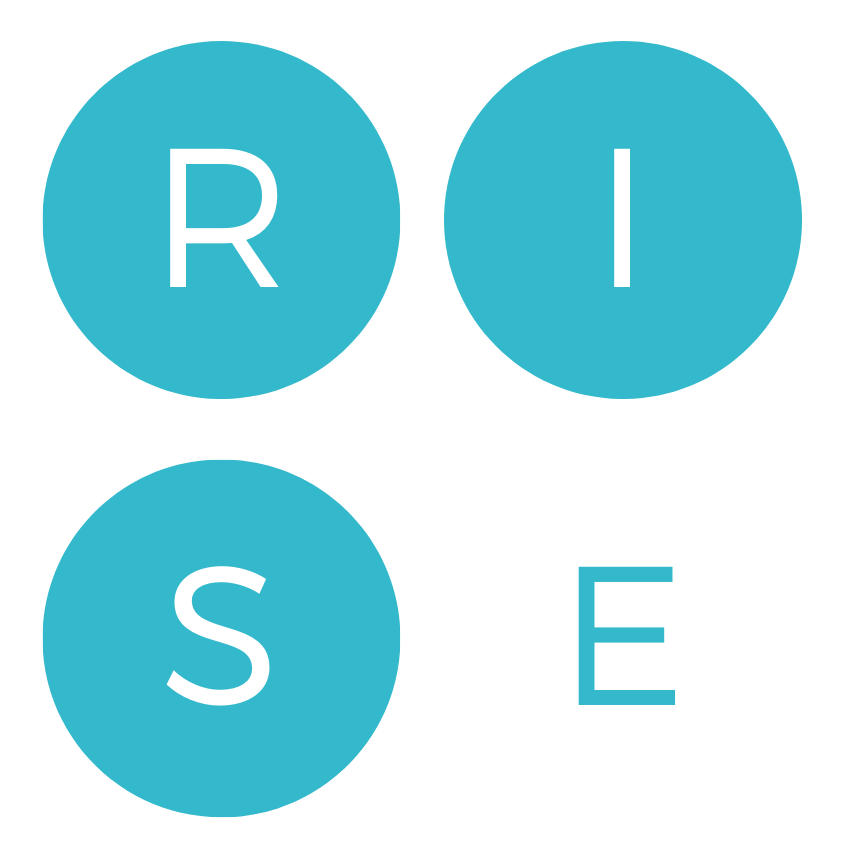A tre settimane dall’elezione di Donald Trump, sono molti gli interrogativi sulla futura amministrazione statunitense. Se negli ultimi giorni i toni da campagna elettorale si sono in parte attenuati, occorre domandarsi se la linea di Trump cambierà anche per quanto riguarda l’attuazione del programma proposto agli americani. La forma che assumerà la politica estera dell’amministrazione Trump è uno dei nodi che destano più interesse. Per cominciare a riflettere sul tema, abbiamo posto alcune domande a Mauro Campus, professore di Storia delle relazioni internazionali presso la Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze.
Durante la campagna elettorale Donald Trump si è spesso pronunciato contro i trattati commerciali internazionali e possiamo ragionevolmente pensare che molti dei voti delle aree più depresse del paese siano stati conquistati anche così. Uscendo però dalla retorica elettorale, pensa che gli Stati Uniti possano tirarsi indietro dalla linea favorevole ai trattati di libero scambio?
Mi pare che si possa affermare che i negoziati di entrambi i principali trattati commerciali (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP e Trans Pacific Partnership Agreement, TPPA), pensati oramai anni fa, erano già compromessi prima dell’elezione di Trump. Quella sorta di “dogma” radicatosi nei primi anni del XXI secolo che confidava nella crescita pacifica, stabile e illimitata non solo dei volumi dei commerci ma delle relazioni economiche internazionali, che vedeva la creazione di una sorta di mercato globale con un’omogeneizzazione e una conseguente riduzione delle garanzie e dei diritti dei lavoratori, è stato frantumato dalla crisi cominciata nel 2008. Tant’è che il TTIP, su cui ci si è così tanto interrogati poiché avrebbe ulteriormente integrato i due principali mercati mondiali, Europa e Stati Uniti, di fatto giace in un limbo negoziale. Limbo che fa presagire la fine dello stesso negoziato, sia perché esiste una forte resistenza delle classi lavoratrici soprattutto in Europa occidentale, sia perché esiste analoga resistenza da parte delle élite europee. Tornando a quanto si può ipotizzare rispetto all’influenza che Trump potrebbe avere sulla politica commerciale degli Stati Uniti, è immaginabile che l’integrazione dei sistemi commerciali che vedono gli Stati Uniti al centro di una rete sempre più globale, subisca una battuta d’arresto. Il che non 2 significa immaginare che gli USA possano tornare ad una sorta neo-isolazionismo. Questo è escludibile poiché la qualità e la quantità dei vincoli che gli USA hanno assunto nel tempo è tale che per diventare un paese protezionista comporterebbe quasi una “inversione identitaria” quale, per fare un esempio, l’uscita dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO); o per fare un altro esempio, mi pare irrealistico che la nuova amministrazione possa imporre dazi del 35% sulle importazioni di automobili, come affermato da Trump durante la campagna elettorale.
Parliamo adesso di Pacifico. I pareri sulla politica di Obama rispetto ai paesi asiatici – il cosiddetto pivot to Asia – sono numerosi e spesso discordanti. Ritiene che l’insediamento di Trump alla Casa Bianca comporterà una battuta d’arresto dei tentativi di Obama di creare rapporti più stretti con i paesi asiatici?
Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario fare un bilancio della politica asiatica delle due amministrazioni Obama. La qual cosa non è semplice perché alcune traiettorie immaginate e attuate da Obama sono ancora in una fase di divenire e le conseguenze non sono valutabili appieno nell’attuale situazione. Non intendo sospendere il giudizio sulla politica estera di Obama, quanto rilevare che gli elementi per dare una valutazione più distesa non sono ancora completamente disponibili. Possiamo però parlare di ciò che è avvenuto in questi anni, ovvero del tentativo di affrontare i teatri della politica internazionale in cui gli Stati Uniti sono impegnati in maniera significativa – e l’Estremo Oriente fra questi – con una visione complessiva. L’amministrazione Obama ha affrontato i grandi problemi globali in maniera organica e in parte con successo, quanto di quella visione possa sopravvivere nella transizione all’amministrazione Trump è difficile dirlo. Tuttavia, possiamo supporre – ed anche temere – che larga parte dell’approccio obamiano sarà superato. Anche mettendo da parte la retorica da campagna elettorale, Trump non si distingue per una conoscenza profonda né dei legami economico-commerciali degli Stati Uniti con il resto del mondo, né dell’impegno profuso dalle amministrazioni Obama per “restaurare” e “stabilizzare” il sistema internazionale.
Una questione di pressante attualità è la guerra civile siriana e i negoziati che vanno avanti oramai da mesi per giungere ad un accordo fra governo siriano ed opposizione riconosciuta. Pensa che la 3 simpatia mai celata di Trump nei confronti di Putin segnerà una svolta in quei negoziati, magari in favore di Bashar al-Assad, come auspicato dal Cremlino?
L’elezione di Trump comporterà un nuovo approccio nei confronti della Federazione Russa, ma questo non solo perché Trump apprezza Putin e la sua azione di politica estera in Medio Oriente, quanto perché la presenza degli Stati Uniti nello scenario internazionale sarà meno pervasiva di quanto è stata negli ultimi venticinque anni e, soprattutto, durante la Segreteria di Stato di Hillary Clinton. Questo perché l’obiettivo di Trump è quello di concentrarsi sulla politica interna. Bisogna auspicare che il partito Repubblicano, nonostante la diffidenza che nutre nei confronti di Trump contribuisca in maniera proattiva alla formazione dell’esecutivo e, dunque, abbia un ruolo nella nomina di un Segretario di Stato capace di muoversi con cognizione fra i dossier più importanti, fra cui quello russo, e dunque riesca a temperare almeno i più macroscopici errori di lettura compiuti da Trump in campagna elettorale a proposito della politica estera delle Federazione russa.
Ritiene quindi che anche il coinvolgimento degli Stati Uniti in alcune aree come quelle del Medio Oriente arretrerà?
Sì, è presumibile anche se non si può parlare di isolazionismo. Farlo per gli Stati Uniti significherebbe tornare alla metà del XIX secolo, neanche all’inizio del XX secolo che pur è stato caratterizzato da una certa forma ritiro dalla partecipazione diretta alla vita internazionale. Chi parla oggi di isolazionismo semplicemente ignora i fondamentali del sistema internazionale contemporaneo. Piuttosto, gli Stati Uniti rivedranno l’impegno universalistico che si attribuirono alla fine del conflitto bipolare.
Arrivando all’Europa e nello specifico all’Unione Europea: si è parlato molto dell’opportunità che l’amministrazione Trump potrebbe offrire per un nuovo sviluppo del progetto di difesa comune europeo. Tenendo conto delle elezioni legislative del prossimo anno (Francia, Germania e Paesi Bassi, per citarne solo alcune), pensa che gli stati membri dell’UE siano disposti a riconsiderare l’idea di un’unione di difesa?
No, non credo nella retorica delle “occasioni perdute” da parte dell’Unione Europea perché l’Unione ha quasi un’occasione al giorno, che costantemente perde. Con Brexit l’UE ha perso circa il 33% dal suo potenziale militare. Se non è successo niente dopo questo evento è prevedibile che non esista 4 una reale possibilità, una spinta coesiva o, per meglio dire, che vi sia all’orizzonte una crisi d’integrazione, per usare le parole di Albert Hirschman. Una crisi di integrazione non nasce dall’esterno. Ciò che al momento caratterizza il processo di integrazione europea è la disgregazione in atto. La futura presidenza Trump segna, semmai, un maggior isolamento dell’Unione Europea: senza il “grande alleato” è difficile immaginare che ci sia un’evoluzione dell’integrazione. Nel 2017 nell’Unione Europea ci sarà un’elezione al mese, il che ci suggerisce che per i prossimi due anni avverrà un ricambio dell’establishment dei singoli stati, mentre l’establishment – piuttosto mediocre – che risiede tra Bruxelles e Strasburgo sarà, di fatto, bloccato. L’unica soluzione sarebbe una rinegoziazione dei Trattati, solo che è difficile immaginare che in una simile circostanza storica un nuovo trattato venga poi ratificato, anche se fosse depurato dal Fiscal Compact e da altri vincoli oggi particolarmente invisi alle opinioni pubbliche dei paesi dell’Unione.
Per concludere, pensa che la Brexit e l’elezione di Trump possano favorire un riavvicinamento fra Stati Uniti e Regno Unito, rinsaldando la tanto spesso citata relazione speciale fra i due paesi?
La “relazione speciale” è perlopiù culturale e, nella sua forma attuale, si è definita dagli anni Cinquanta del XX secolo. I restanti contenuti di cui si è voluta riempire la special relationship sono molto meno significativi, specie nella percezione degli Stati Uniti. Peraltro si tratta di una relazione speciale piuttosto discontinua anche nella storia recente. Possiamo identificare il momento di apice negli anni di Reagan e della Thatcher, sebbene anche la relazione fra Bush e Blair si collocasse all’interno del perimetro della special relationship. Per quanto concerne l’aspetto culturale, il comune fattore linguistico non deve essere mai sottovalutato, soprattutto quando si parla di relazioni internazionali, commerciali e, almeno in parte, sociali. Non credo tuttavia che il Regno Unito possa tornare ad essere l’uccellaccio appollaiato sul lembo del Continente occidentale, o possa rispondere meccanicamente alle indicazioni di Washington, e questo nonostante l’attuale establishment britannico di profilo molto basso.
Elena Cammilli